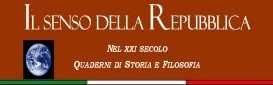 In Maestri e compagni (Passiglì, Firenze 1984) Norberto Bobbio, ricordando l'amico Aldo Capitini, cosi si esprimeva: «Non posso non andare con la mente alle parole di Nietzsche: “Che cosa è il filosofo? Al di là delle scienze: liberazione dalla materia. Al di qua delle religioni: liberazione dagli dei e dai miti”. Ovunque il sistema filosofico, qualunque esso sia, si dissolve, tornano alla ribalta affrontandosi o alleandosi l'al di qua delle Scienze e l'al di là della religione, il sistema astratto e l'antisistema, l'intellettualismo e irrazionalismo.
In Maestri e compagni (Passiglì, Firenze 1984) Norberto Bobbio, ricordando l'amico Aldo Capitini, cosi si esprimeva: «Non posso non andare con la mente alle parole di Nietzsche: “Che cosa è il filosofo? Al di là delle scienze: liberazione dalla materia. Al di qua delle religioni: liberazione dagli dei e dai miti”. Ovunque il sistema filosofico, qualunque esso sia, si dissolve, tornano alla ribalta affrontandosi o alleandosi l'al di qua delle Scienze e l'al di là della religione, il sistema astratto e l'antisistema, l'intellettualismo e irrazionalismo.
E qui, con l'ultimo libro di Stefano Cazzato Di cosa parliamo quando parliamo di fiiosofia? il punto di vista di cinquanta pensatori [Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero (No) 2013], siamo proprio nel mezzo di questo dialogo tra trascendente e immanente, tra speranza e materia, tra astrazione e radicamento. il pensiero filosofico, dei resto, si conferma tale solo nella misura in cui è capace di sempre nuove (ri)aperture di questioni che probabilmente altre discipline tenderebbero a “chiudere” o quantomeno a definire il più possibiie. Anzi, come premette Cazzato stesso, la filosofia sembra andare anche oltre se stessa nel momento in cui finisce per trasformare in problema la propria esistenza (cfr. p. 8).
IL LIBRO, NEL MENTRE, colloquia con la prospettiva filosofica di “cinquanta pensatori” -presentati opportunamente come voci di relativi loro punti di vista sui mondo, sull'uomo e sui significati che l'uomo al mondo va attribuendo-, si chiede e ci chiede, esplicitamente, cosa sia la filosofia. Ecco allora i pungoli alla riflessione offerti da Michelstaedter e da Anders, dalla Nussbaam e da Lévinas, da Adorno e da Russell, da Chomsky e dalla Heller... La struttura del volumeè seplice ed efficace: a un agile profilo dedicato a ciascun autore seguono due altrettanto brevi testi: uno stralcio di un'opera di quell'autore e un commento di Cazzato.
Una delle conclusioni che il lettore viene stimolato a condividere è che il pensiero filosofico non può farsi fermare dalle sabbie mobili che tengono prigioniere le “ingenue filosofie della storia” criticata da un Giulio Preti (cir.pp. 85-86) o le teorie sistematiche “montate” da un Walter Benjamin che «ascrive alla filosofia nuove possibilità espressive e conoscitive, rivendicando ad esempio l'importanza dei frammenti, delle parti, dei dettagli rispetto al tutto» (p. 20) ed esaltando il ruolo dei singoli tasselli all'interno del quadro di significanze del mosaico.
CON UNA POTENZA ESPRESSIVA di rara intensità, è Gilles Deleuze a offrirci la misura di questo tipo di ricerca “aperta” che il volume si propone in quaiche modo, più o meno indirettamente, di promuovere: «Esiste un dìvenire-filosofia che non ha nulla a che vedere con la storia della filosofia, e che passa piuttosto attraverso coloro che la storia della filosofia non giunge a classificare» (pp. 35-36). Non c'e niente da fare: per un approccio autenticamente e genuinamente filosofico non può avere alcuna forma di riduzionismo; siamo piuttosto costretti a problematizzare le questioni fatte oggetto della conoscenza.
E problematizzare - ce lo insegna il tenace lavoro di bottega dell'artigianalìtà educativa propria del mondo della scuola dal quale proviene lo stesso Cazzato - non equivale certo a complicare: ripensiamo invece alla cifra delledomande ossessivamente poste da Socrate ed eviteremo cosi la banalizza zione a favore di un grandangolo sulla realtà.
Giuseppe Moscati
Il senso della Repubblica